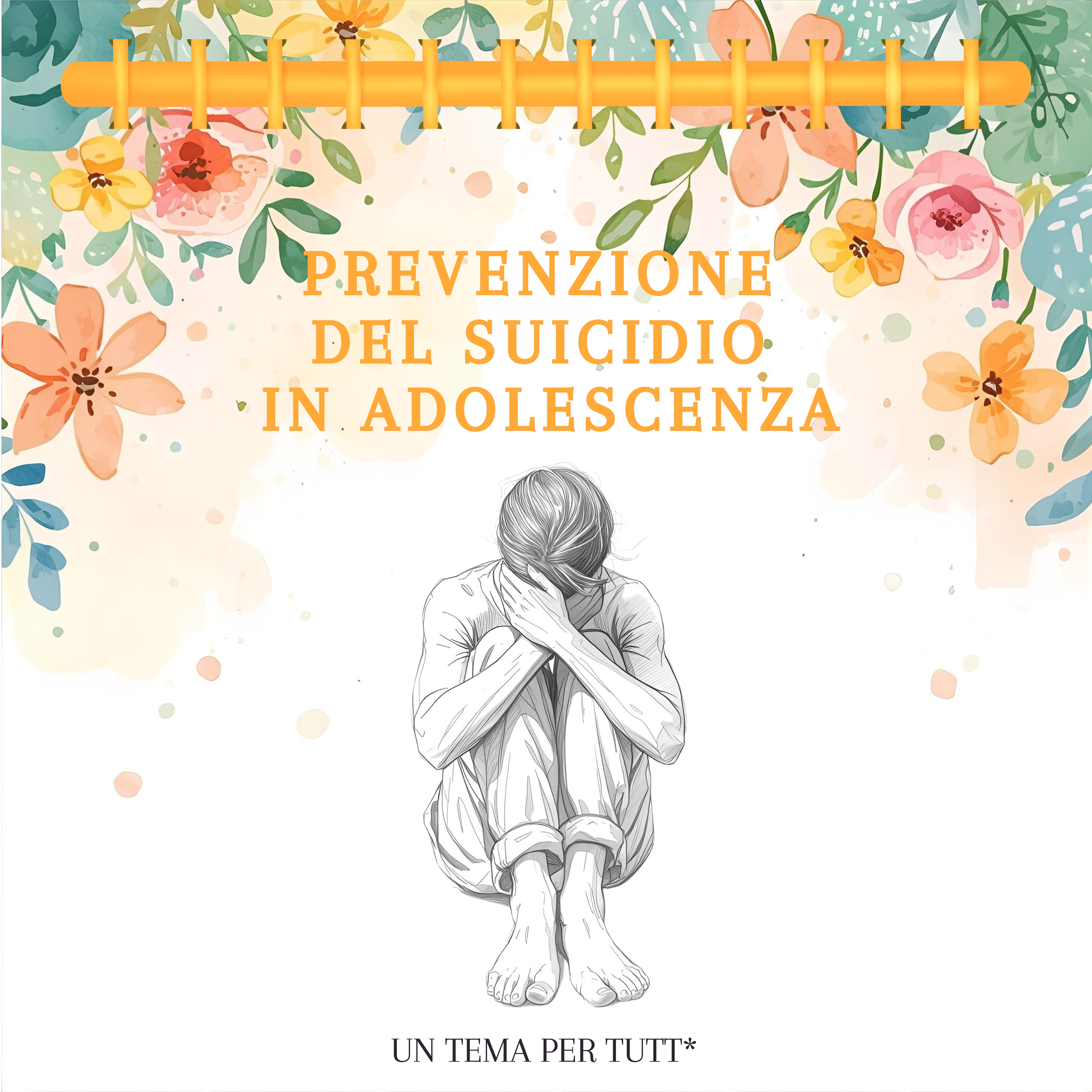
09/10/2025
PREVENZIONE DEL SUICIDIO IN ADOLESCENZA
Dania OsualdellaI dati epidemiologici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che il suicidio è la seconda causa di morte nei ragazzi tra i 14 e i 29 anni (età media: 15 anni).
Più del 90% dei casi totali di suicidio sono associati a disturbi psichici, soprattutto alla depressione e all'abuso di sostanze e ad esserne coinvolte sono soprattutto le ragazze (90%).
Questo fenomeno è diventato ancora più urgente e allarmante negli ultimi anni, durante e dopo la pandemia del Covid-19, quando si è registrato un aumento del 147% di accessi in PS per ideazione suicidaria e dei ricoveri nei reparti di Neuropsichiatria Infantile (+134%).
Questi dati hanno portato quindi la ricerca scientifica a occuparsi in maniera sempre più approfondita del fenomeno, analizzandone le cause per comprenderlo e soprattutto per sviluppare un piano di prevenzione.
Le ricerche svolte sull' ideazione suicidaria tra gli adolescenti sottolineano come si tratti di un fenomeno multifattoriale, alle cui cause partecipano fattori socio-demografici, psicologici e sociologici: tra questi gioca un ruolo rilevante il deterioramento delle relazioni umane.
Quali sono i campanelli di allarme e i fattori psicologici di vulnerabilità di chi si trova in questa situazione?
Tra le caratteristiche individuali a cui prestare attenzione troviamo:
• una percezione del tempo destrutturato: per chi pensa e tenta il suicidio il passato non è mai davvero passato, non riesce a lasciarlo andare ed esso viene vissuto con la stessa intensità del presente. C'è una continua ruminazione sulle occasioni perse e su quello che sarebbe potuto succedere. Allo stesso tempo, il futuro non ha una sua progettualità, perchè nel presente è assente il pensiero positivo, la speranza di migliorare la propria situazione, il desiderio e l'attesa, che sono sostituite invece da un continuo rimuginio sui propri fallimenti ed errori.
Quando il futuro sembra inesistente, è l'esistenza stessa a perdere di significato e la morte sembra l'unica soluzione per mettere a tacere il dolore.
• Modelli di infallibilità e di felicità obbligata, in cui non c'è spazio per il dolore e l'insuccesso, che non possono essere mostrati, verbalizzati e condivisi. Ciò che viene raccontato sui social (e non solo) filtra e mostra gli aspetti positivi e vincenti delle vite altrui, dei coetanei e dei modelli a cui i ragazzi aspirano, in una fase fragile come l'adolescenza, in cui inizia a strutturarsi l'identità, l'immagine di Se' ed il senso di sicurezza. Quest'ultimo, per essere solido, dovrebbe poggiarsi sulla convinzione di avere le risorse per raggiungere le proprie finalità e avere un potere effettivo di soddisfare i propri bisogni, secondo un percorso che preveda anche la possibilità di fallimenti transitori, frustrazioni e perdite.
In questa fase le aspettative interne o esterne di onnipotenza, di perfezionismo, l'aspirazione a standard ideali irrealistici, il pensiero dicotomico bianco/nero “o sono eccezionale o non valgo nulla” rappresentano quindi particolari fattori di rischio.
Questi ragazzi tengono spesso il dolore per sé, sentendosi sbagliati e temendo di essere una delusione ed un peso per gli altri (soprattutto per i genitori). Fondamentale risulta quindi fornire loro un ascolto attento, in cui non si chieda di mettere a tacere la sofferenza (magari sminuendola, banalizzandola o invalidandola), ma si legittimi il dolore, come parte normale del vivere e si aiuti a mediare tra ideale e reale e tra onnipotenza e impotenza. Meglio evitare di dare consigli, perchè, seppur con le migliori intenzioni, potrebbe rendere più critica la situazione, aumentando la loro sensazione di inefficacia personale.
• Incapacità di problem-solving: spesso questi ragazzi hanno più difficoltà di altri a trovare soluzioni ai problemi. Manca la percezione di auto-efficacia (e a volte le capacità oggettive) nell'affrontare gli ostacoli: attendono una soluzione magica dall'esterno, piuttosto che fare appello alle proprie risorse o chiedere aiuto. Al contrario, vedere e spiegare gli eventi avversi in termini di problemi da risolvere, si è rivelato essere un fattore protettivo.
Dalle ricerche emerge che altri fattori psicologici di rischio associati al suicidio o al tentato suicidio sono: la presenza di un disturbo bipolare, di una depressione psicotica o di un disturbo di personalità, la dipendenza da sostanze, la comorbidità con disturbi della condotta, il calo del rendimento scolastico e in generale gli eventi di vita traumatici.
Tra i fattori famigliari di vulnerabilità che aumentano il rischio suicidario emergono invece:
• la non flessibilità e l'invischiamento. Si tratta di famiglie in cui i confini tra i vari membri sono confusi e lo spazio interpersonale è molto ridotto. In queste famiglie quando qualcuno si allontana, l'altro si sente abbandonato. Il ragazzo sente da solo di non poter esistere e di non poter più contare su nessuno.
• Grandi difficoltà ad esprimere le emozioni, le quali non sono un argomento trattabile: quando qualche emozione negativa viene espressa, viene poi invalidata e ridicolizzata dagli altri membri, fino a diventare, di conseguenza, un argomento tabù. Anche l'atteggiamento opposto però, quando le emozioni vengono espresse in modo troppo estremo e disregolato può diventare problematico. Spesso in queste famiglie è presente anche un grande criticismo, la tendenza quindi a sminuire e denigrare continuamente un altro famigliare.
• Aggressività impulsiva (anche assistita), quando i membri della famiglia litigano spesso in modo violento, anche davanti al figlio. I ragazzi possono sentirsi un peso e sviluppare il pensiero che senza di loro, i genitori o gli altri membri starebbero meglio.
• Situazioni di abuso (sessuali e non), maltrattamenti e neglect emotivo. Si assiste al fallimento da parte dell'adulto nel comprendere e assecondare i bisogni emotivi del minore, anche in situazioni traumatiche.
Nei casi più gravi di abuso o di maltrattamento il figlio può diventare il capro espiatorio, quando sono i genitori stessi ad accusarlo di essere la causa dei loro problemi. I maltrattamenti subìti vengono quindi vissuti come meritati. In questo quadro disfunzionale si sviluppa la percezione di essere un peso per la famiglia e si vive l'assenza di un vero senso di appartenenza, al punto che l'ideazione suicidaria viene vista come l'unica alternativa possibile.
Da un punto di vista psicoanalitico questa dinamica si spiega dall'identificazione con l'aggressore: il figlio, come meccanismo di difesa dall'angoscia e dalla rabbia, introietta e assume su di se' parte delle caratteristiche del genitore aggressore, trasformandosi da minacciato a minacciante. Questo influisce anche sulla formazione del Super-io, che rimane arcaico e informe, un giudice assoluto e intransigente che vede l'errore come irreversibile: se sbagli/fallisci devi pagare con la vita. Occorre quindi lavorare per ridurre la pericolosità, l'intransigenza e l'autopunizione del Super-Io.
Non sempre l'ideazione suicidaria viene verbalizzata, si assiste anzi spesso alla rinuncia a chiedere aiuto. Quando però questo desiderio viene dichiarato è importante accogliere sempre il grido d'aiuto e rivolgersi ad un professionista (psicologo o psichiatra) che valuterà quanto l'idea di togliersi la vita sia costante, sia fonte di sollievo e sia attivamente cercata a questo scopo e quanto sia pianificata concretamente. E' importante valutare inoltre se sia conservata o meno qualche speranza di migliorare la situazione. Queste caratteristiche sono tutte indicatori di un rischio concreto e acuto che l'ideazione si trasformi poi in agito e necessitano quindi un intervento immediato.
La cura da parte del clinico e, quando possibile, della famiglia passerà attraverso la relazione e l'ascolto attento del dolore del ragazzo in un clima rassicurante, famigliare e non giudicante che darà voce a quel desiderio di vita che non riesce a trovare espressione.
È importante che anche i famigliari, in situazioni così complesse, si facciano aiutare con un percorso psicologico integrato a quello del figlio, in modo che tutte le figure adulte possano diventare rete di supporto agendo in modo sinergico e “pagaiando” tutti in modo coeso nella stessa direzione.
scarica l'articolo completo






